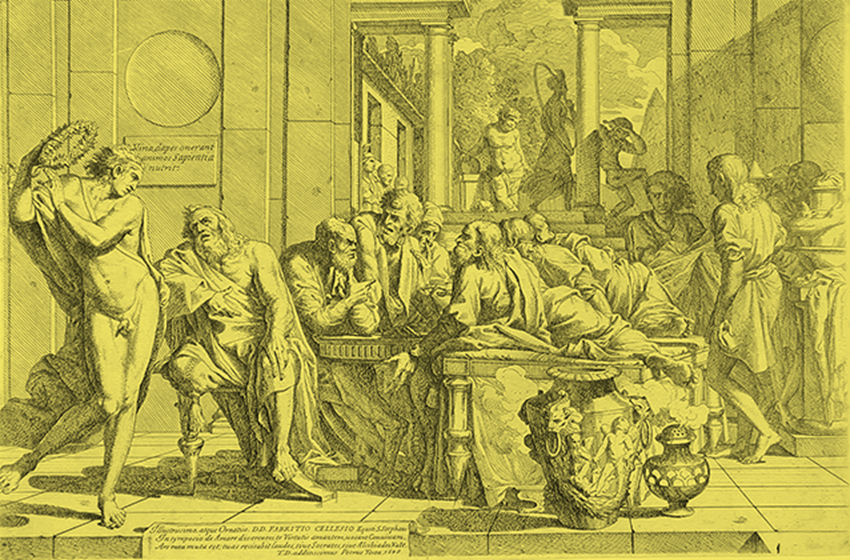La sessione, moderata dai Professori Emilio Di Lorenzo e Leonardo De Luca, inizia con un argomento relativo alla valvulopatia aortica trattato dal Dott. Sergio Berti e riguarda la possibilità di personalizzare la scelta della valvola da utilizzare per l’esecuzione della TAVI poiché una scelta adeguata per ogni paziente porta a risultati migliori. In particolare, i fattori che vanno considerati nella selezione della valvola sono fondamentalmente l’anatomia (dimensione dell’anulus, calcificazione della valvola, bicuspidia aortica, accesso complesso e tortuoso, vasi di piccolo calibro) e le comorbidità (patologia coronarica concomitante, disturbi del sistema di conduzione, funzione ventricolare sinistra ridotta). L’esperienza dell’operatore gioca un ruolo fondamentale nella scelta del dispositivo. Infine, vanno considerate le caratteristiche stesse del dispositivo quali delivery, deploy ed il comportamento post-impianto. Le prospettive future sono relative all’espansione dell’indicazione a TAVI in pazienti giovani (<75 anni), rigurgito aortico, valvola aortica bicuspide, pazienti asintomatici e stenosi aortica moderata, sottolineando il concetto che il grado di severità della stenosi aortica non si valuta unicamente con il gradiente transvalvolare ma anche con altri elementi relativi alla funzione ventricolare sinistra. Conclude affermando che la TAVI ha rappresentato una svolta rivoluzionaria nella pratica clinica trasformando radicalmente l’approccio terapeutico alle valvulopatie aortiche e contribuendo in modo significativo al miglioramento dell’assistenza ai pazienti. Al giorno d’oggi la TAVI viene considerata la procedura standard non solo per pazienti inoperabili perché ad alto rischio, ma anche per pazienti a rischio intermedio e basso. Tuttavia, rimangono delle sfide importanti da affrontare, tra queste la durata nel tempo delle valvole impiantate, ma con uno sguardo al futuro, le direzioni da seguire sono lo sviluppo di nuove tecnologie con dispositivi TAVI sempre più personalizzati, l’estensione dell’indicazione per l’utilizzo della TAVI e l’integrazione dell’intelligenza artificiale delle tecniche di imaging avanzato.
Cambiando argomento, la sessione continua con l’interessante relazione del Professor Carlo Di Mario sui progressi del trattamento transcatetere della valvulopatia mitralica, facendo anzitutto riferimento ai trial clinici sull’insufficienza mitralica secondaria trattata con TEER, il cui confronto evidenzia come l’efficacia delle terapie vari significativamente in base ai pazienti arruolati. Lo studio MITRA-FR ha coinvolto pazienti con insufficienza mitralica meno severa ma con un ventricolo sinistro molto dilatato (circa 252 ml), e lo studio non ha evidenziato benefici significativi in termini di mortalità o riduzione dei ricoveri per scompenso cardiaco. Lo studio COAPT ha selezionato pazienti con insufficienza mitralica severa ma con ventricolo sinistro meno dilatato (circa 192 ml) ed in questo caso è stata osservata una riduzione significativa sia in termini di mortalità che per ospedalizzazione per scompenso cardiaco. Lo studio RESHAPE-HF2 ha considerato pazienti con insufficienza mitralica moderata e un ventricolo sinistro di dimensioni intermedie (205 ml) e i risultati indicano una riduzione dei ricoveri per scompenso cardiaco ma non del tasso di mortalità. Perché risultati così diversi? Il messaggio chiave è che i risultati clinici della TEER dipendono dalla corretta selezione dei pazienti basata sulla proporzionalità del rigurgito mitralico rispetto alla dimensione del ventricolo sinistro (Ipoproporzionata: MR non severo rispetto a un ventricolo sinistro dilatato, proporzionata: MR in equilibrio con la dimensione del ventricolo, disproporzionata: MR severa in un ventricolo relativamente piccolo o MR isolata e non correlata a dilatazione ventricolare). Questo concetto è cruciale per comprendere le differenze tra i trial e migliorare la selezione dei candidati al trattamento. Ulteriormente sottolinea che la riparazione chirurgica dell’insufficienza mitralica funzionale va riservata a pazienti con concomitante indicazione a chirurgia aortica, tricuspidale o coronarica o con controindicazioni anatomiche alla clip. L’ecografia intracardiaca, la miniaturizzazione di probes transesofagei e la meccanizzazione dei delivery systems e della sonda eco ulteriormente semplificheranno la tecnica. Una residua limitazione rimane la presenza di degenerazione mitralica con calcificazione dell’anello estesa ai lembi, proibitiva per TEER e challenging anche per le nuove valvole con necessità di applicare tecniche di preparazione complesse (ASH, LAMPOON, SESAME).
Il Professor Mauro Rinaldi tratta l’argomento relativo alla chirurgia mininvasiva della valvola mitrale che riporta un certo numero di vantaggi, tra cui minor trauma chirurgico con conseguente riduzione della perdita ematica e della necessità di trasfusione, miglior risultato estetico e riduzione della degenza ospedaliera con un più rapido ritorno alla normale attività. Sebbene il dato su una sopravvivenza superiore non sia stato ancora confermato, la chirurgia mininvasiva ha dimostrato risultati equivalenti alla chirurgia tradizionale in termini di mortalità perioperatoria a lungo termine e tasso di successo della riparazione valvolare. La chirurgia della valvola mitrale continua a evolversi offrendo ai pazienti opzioni sempre meno invasive e alquanto efficaci. È stato inoltre presentato uno studio relativo agli esiti della riparazione mitralica trans-apicale non chirurgica mediante impianto di neocorde in pazienti con prolasso del lembo mitralico posteriore coinvolgente il segmento P2 e i risultati evidenziano un tasso di successo dell’86% a 5 anni con un numero significativo di pazienti vivi e valvola mitralica stabile nel tempo e con mantenimento dei benefici clinici.
Il discorso si sposta sulla valvola aortica individuando due diversi approcci. L’approccio con mini-sternotomia è più vicino alla chirurgia sternotomica tradizionale, mantenendo però alcuni benefici della chirurgia mininvasiva, come un accesso più diretto; prevede l’uso di cannulazione centrale e cardioplegia standard. Gli studi clinici non evidenziano differenze significative tra mini-sternotomia e sternotomia completa in termini di mortalità precoce e complicanze. Tuttavia, l’approccio con mini-sternotomia, mostra risultati migliori in termini di perdita di sangue, necessità di trasfusioni, dolore post-operatorio e durata della degenza. L’approccio con mini-toracotomia rappresenta un’alternativa alla chirurgia tradizionale con numerosi vantaggi, quali incisione cutanea più piccola, nessuna sezione di steno e coste, utilizzo della cannulazione arteriosa periferica. Tuttavia, richiede lo studio preoperatorio dei vasi femorali mediante TC e insufflazione di CO2 per migliorare la visibilità del campo operatorio. Nel contesto della riparazione della valvola aortica gli interventi mirano principalmente a ispezionare direttamente la valvola e rimodellare l’anello valvolare. L’introduzione di nuove tecnologie come i sistemi 3D-vision e i robot Da Vinci ha contribuito significativamente al miglioramento dei risultati clinici, ridurre l’invasività degli interventi ed espandere le indicazioni di queste tecniche ad una popolazione più ampia.
La sessione si conclude con la relazione del Professor Paolo Golino sull’approccio alla patologa tricuspidalica, sottolineando che l’insufficienza tricuspidalica è altamente impattante sulla prognosi del paziente. Esistono studi clinici randomizzati che indagano l’efficacia dei dispositivi transacatetere: TRILUMINATE (Triclip) che ha dimostrato un migliramento della qualità di vita e una riduzione dei ricoveri per scompenso, con una ridotta necessità di chirurgia valvolare. CLASP II TR (Pascal) è uno studio in corso che valuta mortalità, necessità di trapianto o supporto meccanico (RVAD), chirurgia sulla tricuspide, ospedalizzazione per scompenso e qualita della vita. TRISCEND II (dispositivo Evoque) ha confermato beneficio significativo su molteplici aspetti, tra cui qualità di vita, classe NYHA e distanza percorsa al test del cammino. Tutti questi studi concordano sulla efficacia del trattamento transcatetere della tricuspide per pazienti ad alto rischio chirurgico ma è fondamentale considerare la fase evolutiva della malattia. L’ Early-stage è caratterizzato da un iniziale rimodellamento dell’anello tricuspidalico e una dilatazione ventricolare destra ancora compensata. In questa fase i pazienti possono essere trattati con maggiore successo. Nel Mid-stage si assiste ad evidente dilatazione del ventricolo destro con comparsa di disfunzione ventricolare, ma con sintomi ancora controllabili. Questo è considerato il momento più appropriato per l’intervento che può migliorare significativamente la prognosi. Il Late-stage in cui c’è severa disfunzione ventricolare destra con segni di congestione sistemica, seppur l’intervento è possibile, questo risulta essere associato a rischio maggiore e beneficio limitato. Il trattamento tardivo, pertanto, riduce le probabilità di successo dell’intervento e di recupero funzionale del paziente.